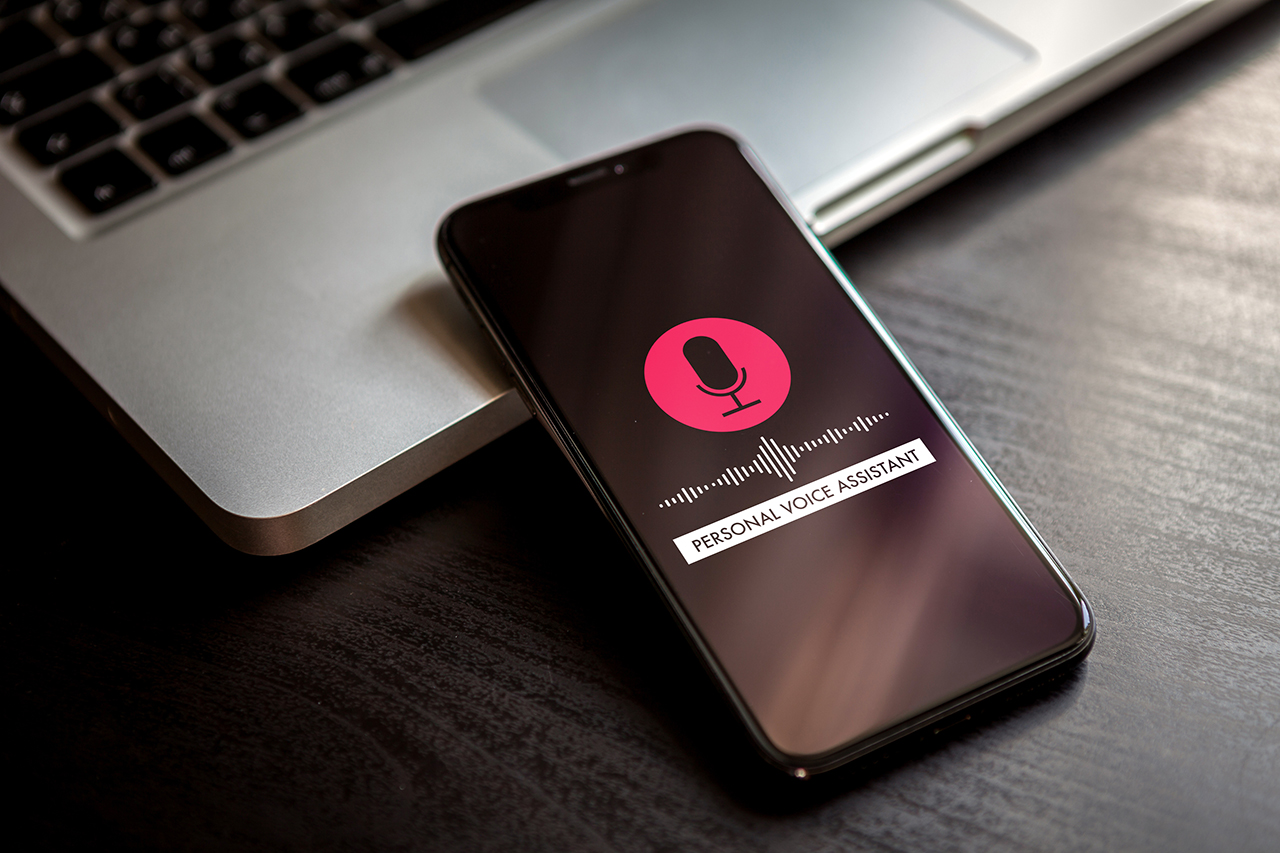Se l’intervento necessita di accesso nell’appartamento del moroso però occorre un via libera del giudice
Nel caso in cui la morosità si protragga per un semestre, l’amministratore ha il diritto di sospendere il condomino dall’utilizzo dei servizi comuni che possono essere goduti separatamente, senza necessità di ottenere un’autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria. Tuttavia, è l’amministratore a doversi assumere la responsabilità di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti (articolo 63, comma 3 delle disposizioni di attuazione del Codice civile).
Sospensione servizio acqua calda
La norma era stata invocata dal condominio nel ricorso per provvedimenti urgenti, al fine di ottenere la sospensione del servizio di acqua calda sanitaria e riscaldamento nei confronti di una condomina morosa da oltre sei mesi (Tribunale di Perugia, ordinanza 1036/2025).
Tuttavia, essendo l’impianto centralizzato, le derivazioni individuali che corrispondevano alle utenze si trovavano all’interno dei singoli appartamenti, rendendo necessario accedere all’immobile per intervenire sugli attacchi dell’acqua sanitaria e del riscaldamento al fine di interromperne l’erogazione.
Per questo motivo, il condominio aveva richiesto al giudice l’autorizzazione ad accedere all’appartamento della controparte, sostenendo la presenza del fumus boni iuris, vista la morosità protratta per oltre sei mesi, e del periculum in mora, considerando la significativa entità del debito accumulato e il conseguente rischio di insolvenza del condominio nei confronti del fornitore.
L’esito
Con l’instaurazione rituale del contraddittorio, la parte convenuta era rimasta contumace. Il Tribunale ha accolto il ricorso. Il giudice ha evidenziato che, nel caso specifico, non era in discussione il diritto di procedere al distacco temporaneo di quei servizi comuni che possono essere fruiti separatamente senza necessità di autorizzazione giudiziaria, tra cui figurano la fornitura di acqua calda sanitaria e quella destinata al riscaldamento, giustificato da una morosità della resistente ben superiore al semestre. Tuttavia, ciò che si poneva come questione era la necessità di ottenere un’autorizzazione per accedere alla proprietà della contumace al fine di sospendere il servizio. Tale esigenza era dimostrata dalla presenza di un pericolo imminente, considerando la durata della morosità e la necessità dell’intervento per arginare l’aggravarsi del danno. L’obiettivo era evitare che, a causa dell’accumulo crescente del debito, gli altri condòmini fossero costretti a rispondere solidalmente per le somme dovute, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, delle disposizioni attuative del Codice civile.
Conclusioni
Per i motivi sopra esposti, il Tribunale ha disposto che la parte resistente permetta immediatamente all’amministratore, assistito da personale tecnico qualificato, di accedere al proprio immobile, limitatamente a quanto necessario per interrompere le derivazioni di acqua calda sanitaria e di riscaldamento.
In definitiva, il condominio non è tenuto a rivolgersi al giudice per ottenere l’autorizzazione a sospendere il servizio al condomino moroso, trattandosi di un diritto già riconosciuto al condominio. Tuttavia, è necessario il ricorso al giudice per ottenere il permesso di accedere all’unità abitativa del condomino in questione e procedere con gli interventi tecnici indispensabili alla sospensione del servizio.